Vilém Flusser – Per una filosofia della fotografia
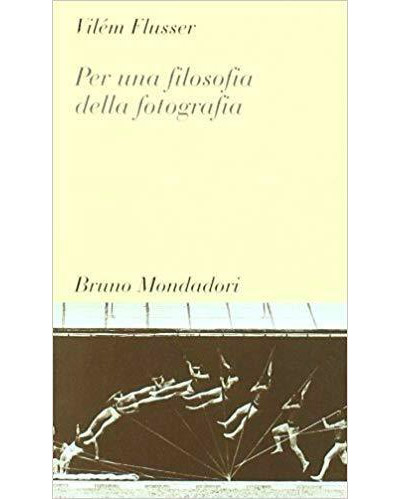 Il saggio “Per una filosofia della fotografia” è stato scritto nel 1983 da Vilém Flusser (nato a Praga il 12 maggio 1920 e morto il 27 novembre 1991 sempre a Praga), filosofo e studioso cecoslovacco. La prima versione italiana del libro risale al 1987 (Agorà Editrice).
Il saggio “Per una filosofia della fotografia” è stato scritto nel 1983 da Vilém Flusser (nato a Praga il 12 maggio 1920 e morto il 27 novembre 1991 sempre a Praga), filosofo e studioso cecoslovacco. La prima versione italiana del libro risale al 1987 (Agorà Editrice).
Si tratta di un piccolo libro, ma dal grande contenuto. Spesso viene fatto leggere anche nei corsi di fotografia all’università o all’accademia delle belle arti.
Inizialmente la lettura è difficile, ma è un testo che vale la pena leggere, in quanto esprime concetti ancora attuali in merito alla fotografia e al rapporto tra il fotografo e la macchina fotografica.
Il fotografo deve essere superiore alla fotocamera, non farsi sottomettere dai suoi programmi, non cadere nella trappola di produrre immagini ridondanti, che non dicono nulla.
La differenza tra “colui che scatta foto” e il “fotografo” è che il fotografo cerca possibilità inesplorate, vuole realizzare nuove immagini informative, mentre “chi scatta foto” realizza solo immagini ridondanti, superflue e senza informazioni.
È un libro da leggere con calma, riflettendo sui vari concetti espressi.
Riporto qui di seguito un riassunto dei vari capitoli, con i concetti chiave.
1. L’immagine
Le immagini sono superfici significanti. Indicano qualcosa nello spazio tempo là fuori, qualcosa che in quanto astrazioni devono rendere a noi rappresentabile.
Per decodificare le immagini, usiamo l’immaginazione, mediante processi di analisi e scanning.
Le immagini non sono complessi simbolici denotativi (univoci, come ad esempio i numeri), ma connotativi (plurivoci), quindi lasciano spazio alle interpretazioni.
Le immagini sono una mediazione tra il mondo e l’uomo. Ma anziché rappresentare il mondo, lo alterano. L’uomo si dimentica di aver creato lui le immagini per orientarsi nel mondo grazie ad esse. Quindi l’uomo si mette a vivere in funzione delle immagini da lui create, l’immaginazione diventa allucinazione.
I testi hanno l’intento di spiegare le immagini. E al tempo stesso le immagini illustrano i testi per renderli rappresentabili. E in questa lotta tra testo e immagine, le immagini diventano sempre più concettuali e i testi diventano sempre più immaginativi.
Nel momento in cui i testi diventano ermetici e irrappresentabili, impossibili da fissare in immagini, l’uomo vive in funzione solo dei suoi testi. Per questo vengono inventate le “immagini tecniche”, per rendere i testi nuovamente rappresentabili.
2. L’immagine tecnica
Un’immagine tecnica è un’immagine prodotta da apparecchi. L’uomo vede queste immagini come “finestre”. Crede a queste immagini tecniche come fossero i suoi occhi. Ma l’oggettività delle immagini tecniche è illusoria.
Nel caos creato dalle immagini tecniche, fra le immagini e il loro significato si inserisce anche un altro fattore: la macchina fotografica (apparecchio / operatore). La fotocamera non interrompe la catena tra immagine e significato. C’è un input e un output, ma lo svolgimento che avviene all’interno non è chiaro, è una scatola nera (black box). La codifica delle immagini tecniche avviene quindi all’interno di questo black box.
Le immagini tecniche caricano la vita di una nuova magia, che non è la stessa magia delle immagini tradizionali. Il fascino che emana lo schermo della tv o quello cinematografico è diverso da quello che avvertiamo di fronte alle immagini della preistoria, quelle delle caverne o delle tombe etrusche.
La fotografia, come prima immagine tecnica, fu inventata nel XIX secolo per caricare nuovamente le immagini di magia. L’invenzione della fotografia è un evento storico come lo fu l’invenzione della scrittura. La scrittura è nata come lotta contro l’idolatria. La fotografia è nata come lotta contro la testolatria.
Nel XIX secolo, tutti sapevano leggere, grazie all’obbligo scolastico e all’avvento dei testi a prezzo accessibile a tutti. In questo contesto, la cultura si divise in tre branche: quella delle belle arti (con immagini tradizionali ma arricchite dal punto di vista concettuale e tecnico), quella della scienza e della tecnica (con libri ermetici), e quella dei larghi strati sociali (nutrita di testi a buon mercato). In questa situazione, le immagini tecniche servivano per evitare un disgregamento della cultura, erano un “codice” che doveva valer per tutta la società, un codice universalmente valido, un denominatore comune a tutta la cultura.
Ogni attività artistica, scientifica o politica e ogni azione quotidiana vuole essere fotografata, filmata, ripresa con la videocamera. Tutto aspira a restare eternamente nella memoria e a diventare ripetibile all’infinito. Niente resiste alla forza d’attrazione delle immagini tecniche.
3. L’apparecchio fotografico
Bisogna chiedersi quale sia la posizione ontologica degli apparecchi. Gli apparecchi sono parte integrante di una cultura e quindi negli apparecchi possiamo riconoscere una cultura.
Esistono due tipi di oggetti culturali: i beni di consumo (che devono essere consumati) e gli utensili (che servono a produrre beni di consumo). Se definiamo l’apparecchio fotografico come un utensile il cui intento è produrre fotografie, sorgono dei dubbi. La fotografia è un bene di consumo come una scarpa o una mela?
Gli utensili sono prolungamenti del corpo umano (denti, dita, mani, braccia, gambe prolungate). Ma con la rivoluzione industriale gli utensili si fanno più grandi, potenti e costosi, diventano “macchine”. La macchina fotografica diventa quindi una macchina da vista. Con la rivoluzione industriale si inverte anche il rapporto tra uomo e utensili. Prima l’uomo era circondato da utensili, dopo la rivoluzione industriale la macchina è circondata da uomini. Prima l’utensile era la variabile e l’uomo la costante. Poi l’uomo divenne la variabile e la macchina la costante. Prima l’utensile funzionava in funzione dell’uomo, poi l’uomo ha iniziato a lavorare in funzione della macchina, diventando un “proletario”.
Anche il fotografo è un proletario? Il fotografo non lavora, ma produce, elabora, immagazzina simboli, così come lo fa lo scrittore, il pittore, il compositore. I prodotti sono libri, dipinti, partiture che sono oggetti che non venivano consumati, ma erano portatori di informazioni. Prima dell’avvento degli apparecchi questo era lavoro intellettuale. La cultura rientrava nella categoria dell’informazione, non del lavoro.
L’apparecchio fotografico produce simboli. È programmato per generare fotografie.
Ogni fotografia realizza una delle possibilità contenute nel programma dell’apparecchio fotografico. Queste possibilità sono tante, ma finite.
Il fotografo è impegnato a esaurire il programma fotografico, realizzando tutte le possibilità. Si impegna a trovare le possibilità ancora inesplorate. È alla ricerca di nuove possibilità di produrre informazioni e sfruttare il programma fotografico. Il suo interesse è concentrato sull’apparecchio, e il mondo è solo un pretesto per realizzare le possibilità dell’apparecchio. Il fotografo non lavora, non vuole trasformare il mondo, ma è alla ricerca di informazioni. Il fotografo si insinua nell’apparecchio per carpirne tutti i segreti. A differenza dell’artigiano circondato da utensili e dell’operaio che sta alla macchina, il fotografo è all’interno dell’apparecchio, e vi è connesso. È una funzione nuova, dove l’uomo non è né la costante né la variabile, ma in cui uomo e apparecchio si confondono e fanno tutt’uno.
Le possibilità che racchiude l’apparecchio fotografico devono superare le capacità del fotografo di esaurirle. L’apparecchio fotografico è un black box. E per il fotografo, proprio l’oscurità della scatola è il motivo per fotografare. È capace di governare la scatola, conosce l’input e l’output (la fotografia), anche se non sa cosa avviene all’interno dell’apparecchio. La macchina fotografica è un utensile intelligente, perché genera immagini in modo automatico. Quindi il fotografo non deve più concentrarsi, può dedicarsi solo al gioco con la fotocamera. Infatti l’atto di imprimere l’immagine sulla superficie avviene in modo automatico, lasciando al fotografo solo il lato ludico dell’apparecchio. L’apparecchio diventa quindi un giocattolo complesso, al punto che chi ci gioca non è in grado di comprenderlo.
4. Il gesto fotografico
Il fotografo, uomo munito di apparecchio fotografico, si muove come un cacciatore, cercando la sua cacciagione nella giungla degli oggetti culturali. I sentieri fotografici nella giungla occidentale sono differenti da quelli della giungla orientale, e la critica fotografica, dovrebbe poter ricostruire queste condizioni culturali a partire dalla fotografia. Ma non è possibile decifrare la condizione culturale del fotografo perché ciò che appare nella fotografia sono le categorie dell’apparecchio fotografico. Può selezionare una combinazione di categorie, ma la sua liberà resta limitata alle categorie dell’apparecchio.
Mentre l’apparecchio funziona in funzione dell’intenzione del fotografo, questa stessa intenzione funziona in funzione del programma dell’apparecchio.
Lo stesso vale per l’oggetto da fotografare. Il fotografo può registrare tutto, ma in realtà può registrare solo ciò che è fotografabile, cioè tutto ciò che figura nel programma. Di conseguenza, nonostante la scelta dell’oggetto da registrare sia libera, è comunque una funzione del programma dell’apparecchio.
Il fotografo quando sceglie le categorie può anche mettere in gioco i suoi criteri estetici, gnoseologici e politici, per creare immagini artistiche, scientifiche o politiche, per le quali l’apparecchio non sia che un mezzo. Ma i suoi criteri apparentemente esterni all’apparecchio restano comunque sottomessi al programma dell’apparecchio.
La fotografia è un’immagine di concetti. Per poter regolare l’apparecchio per realizzare immagini artistiche, scientifiche o politiche, il fotografo deve possedere concetti d’arte, scienza e politica.
L’immaginazione dell’apparecchio è superiore a quella del fotografo. Le possibilità contenute nell’apparecchio sono inesauribili, ed è impossibile fotografare tutto ciò che è fotografabile. Il fotografo cerca nel programma dell’apparecchio possibilità ancora inesplorate, immagini informative mai viste prima.
Il gesto fotografico si scompone in una sequenza di salti con cui il fotografo supera gli ostacoli invisibili delle singole categorie dello spazio-tempo. Ogni volta che il fotografo si imbatte in un ostacolo, scopre che il suo punto di vista è concentrato sull’oggetto e che l’apparecchio gli offre un’infinità di altri punti di vista. Scopre che non si tratta di assumere un punto di vista privilegiato ma di realizzare il maggior numero possibile di punti di vista.
Il gesto fotografico è un momento venatorio, in cui fotografo e apparecchio si confondono in una funzione invisibile. Questo gesto dà la caccia a nuovi stati di cose, a situazioni mai viste prima, all’improbabile, a informazioni. La struttura del gesto fotografico è quantica: è un dubbio composto di esitazioni e decisioni puntiformi. È un gesto per il quale la realtà è l’informazione, non il significato di tale informazione.
Il risultato del gesto fotografico sono le fotografie.
5. La fotografia
Le fotografie sono onnipresenti. Le troviamo in album, libri, vetrine, manifesti, ecc.
Per chi osserva le foto in modo ingenuo, queste rappresentano il mondo. L’osservatore ingenuo pensa di vedere, attraverso le foto, il mondo là fuori, e pensa che l’universo della fotografia coincida con il mondo là fuori.
Ma qual è la relazione tra universo fotografico (a colori o in bianco e nero) e mondo là fuori?
Il bianco e nero sono concetti teorici, gli stati di cose in bianco e nero non possono esistere effettivamente nel mondo. Le foto in bianco e nero, invece esistono effettivamente. Il grigio (unione di bianco e nero) è il colore della teoria. Le foto in bianco e nero sono immagini di teorie. Molti fotografi preferiscono fotografare in bianco e nero perché in queste foto si manifesta più chiaramente il significato proprio della fotografia, ovvero il mondo dei concetti.
Ma anche i colori delle foto sono teorici come quelli in bianco e nero, sono concetti. Il verde del prato fotografato è un’immagine del concetto di verde come si presenta nella teoria della chimica, e la macchina fotografia è programmata per tradurre questo concetto in immagine. Le fotografie a colori hanno un livello di astrazione maggiore di quelle in bianco e nero. Infatti le foto in bianco e nero rivelano la loro origine teorica in modo più chiaro. Mentre i colori, più diventano “autentici”, più sono menzogneri e più dissimulano la loro origine teorica.
L’intenzione del fotografo è codificare i suoi concetti sotto forma di immagini fotografiche, per offrire informazioni agli altri e rendersi immortale nella memoria altrui grazie alle sue foto.
Il programma dell’apparecchio fotografico è invece quello di codificare sotto forma di immagini i concetti che sono in esso programmati, per programmare la società ad assumere un comportamento a feedback favorevole al progressivo miglioramento degli apparecchi, per ottenere foto sempre migliori.
La critica fotografica dovrebbe cercare di capire in che modo il fotografo è riuscito a sottomettere l’apparecchio alla propria intenzione e grazie a quale metodo. E al tempo stesso dovrebbe chiedersi in che misura l’apparecchio è riuscito a deviare l’intenzione del fotografo a favore del programma dell’apparecchio, e grazie a quale merito.
In quest’ottica la migliore fotografia sarà quella in cui l’intenzione umana del fotografo ha sconfitto il programma dell’apparecchio.
Esistono buone fotografie, in cui lo spirito umano trionfa sul programma, ma nell’universo fotografico i programmi sono sempre più bravi a deviare le intenzioni umane verso le funzioni dell’apparecchio.
In sostanza, le fotografie sono, come tutte le immagini tecniche, concetti cifrati sotto forma di strati di cose, e precisamente si tratta di concetti del fotografo e di concetti che sono stati programmati nell’apparecchio.
La critica ha il compito di decifrare in ogni fotografia queste due codificazioni. Se non ci riuscirà, le fotografie rimarranno indecifrate e appariranno come riproduzioni di stati di cose nel mondo là fuori, come se essi si fossero riprodotti da sé su una superficie.
6. La distribuzione fotografica
Nel processo di manipolazione delle informazioni chiamato “comunicazione”, le informazioni prima vengono generate, e poi vengono distribuite.
L’apparecchio fotografico è programmato per diffondere informazioni. Le fotografie sono dei volantini che vengono distribuiti tramite riproduzione (la fotocamera genera infatti dei negativi da cui è possibile ottenere infinite copie). Il valore della fotografia non risiede nella cosa, ma nell’informazione che porta libera e riproducibile sulla sua superficie.
Nell’ambito fotografico l’interesse si sposta dall’oggetto all’informazione. La fotografia cartacea segna il primo passo verso la svalutazione della cosa e la valorizzazione dell’informazione.
Detiene il potere non chi possiede la fotografia, ma chi ha generato l’informazione che si trova su di essa.
Quando fotografa, il fotografo ha già in mente il canale su cui verrà distribuita la foto, e codifica la foto in funzione di questo canale.
Quindi la simbiosi tra apparecchio e fotografo si riflette anche nel canale. Ad esempio: il fotografo fotografa per un determinato giornale perché il giornale gli permette di raggiungere migliaia di destinatari o perché è pagato dal giornale. Quindi agisce credendo di utilizzare il giornale come mezzo. Il giornale è dell’idea di usare la foto per illustrare i suoi articoli, per programmare meglio i suoi lettori, e che quindi il fotografo sia un funzionario dell’apparato giornalistico. Sapendo che verranno pubblicate solo foto che rientrano nel programma del giornale, il fotografo cercherà di eludere la censura del giornale introducendo nell’immagine elementi estetici, politici e gnoseologici.
Ogni foto diffusa permette alla critica fotografica di ricostruire questa lotta tra fotografo e canale. Ma i critici ignorano che i canali (i media) determinano il significato delle foto, e favoriscono così l’intenzione dei canali di diventare invisibili. I critici funzionano così in funzione dei canali, lasciando che i canali (cioè i media) scompaiano dal campo visivo dei destinatari.
7. La ricezione della fotografia
Oggi (cioè nel 1983 quando è stato scritto il libro) quasi tutti possiedono una macchina fotografica e fanno foto. Ma chi sa fare foto non deve necessariamente saperle decifrare.
Il fotoamatore può essere un analfabeta fotografico. La macchina fotografica acquistata sarà sempre l’ultimo modello, meno costoso, più piccolo, più efficiente dei modelli precedenti. Questo miglioramento si fonda sul feedback con cui i dilettanti alimentano l’industria fotografica.
Il dilettante si distingue dal fotografo per la gioia di fronte alla complessità strutturale del suo giocattolo. Non è alla ricerca di nuove informazioni, dell’improbabile, ma vuole semplificare sempre di più la propria funzione grazie a un’automazione sempre più perfetta. L’automaticità dell’apparecchio fotografico lo inebria. Il dilettante riesce a vedere il mondo solo attraverso l’apparecchio e secondo le categorie fotografiche. È divorato dall’avidità del suo apparecchio, non è “al di sopra” dell’atto fotografico. Chi sfoglia un suo album di foto non vi riconosce esperienze, conoscenze o valori di un uomo fissati in immagine, ma solo possibilità dell’apparecchio realizzate in modo automatico.
Il fotografo, invece, è interessato a vedere in modo sempre nuovo, a produrre stati di cose sempre nuovi, informativi.
Le foto sono percepite come oggetti privi di valore, che chiunque è in grado di produrre e con cui tutti possono fare ciò che vogliono.
Sono però di fatto le foto che trattano noi, per programmarci ad assumere un comportamento rituale al servizio di un feedback per gli apparecchi. Le foto sopprimono la nostra coscienza critica, per farci dimenticare la stupida assurdità del funzionamento. Creano quindi una sorta di cerchio magico che ci circonda sotto forma di universo fotografico. Ma bisogna rompere questo cerchio magico.
8. L’universo fotografico
Ci siamo abituati alle fotografie al punto che non percepiamo neppure la maggior parte delle foto, perché sono ridondanti.
La sfida del fotografo deve essere quella di contrapporre a questa marea di foto ridondanti, delle foto informative.
Trovarsi nell’universo fotografico significa vivere, conoscere e valutare il mondo in funzione delle foto. Questo genere di esistenza in cui ogni esperienza, conoscenza, valutazione e azione può essere scomposta e analizzata nelle singole foto, è l’esistenza dei robot.
L’universo fotografico, e in generale tutti gli universi degli apparecchi, robotizzano quindi l’uomo e la società.
Gli apparecchi devono farsi carico del lavoro umano. Ad esempio l’apparecchio fotografico emancipa l’uomo dalla necessità di manipolare un pennello. Ma gli apparecchi sono però caduti in mano ai capitalisti. Ora gli apparecchi servono gli interessi di queste persone. Anche le fotografie quindi devono essere decifrate come espressione degli interessi nascosti di coloro che detengono il potere.
Gli apparecchi funzionano ormai come fine a sé stessi, automaticamente, all’unico scopo di conservare e migliorare se stessi.
Qualcuno lotta contro questa programmazione automatica. I fotografi cercando di produrre immagini informative, cioè foto che non siano contenute nel programma dell’apparecchio. I critici cercano di cogliere il gioco automatico della programmazione. Il compito della filosofia della fotografia è quindi quello di mettere a nudo questa lotta tra uomo e apparecchio nel campo della fotografia, e riflettere su una possibile soluzione del conflitto.
9. La necessità di una filosofia della fotografia
Alla base di ogni filosofia della fotografia ci sono quattro concetti: immagine, apparecchio, programma, informazione.
In base a questi, una definizione di fotografia è la seguente: la fotografia è un’immagine generata e distribuita da apparecchi secondo programma, e la cui presunta funzione è informare.
Ciascuno di questi concetti implica ulteriori concetti: l’immagine implica la magia, l’apparecchio implica l’automazione e il gioco, il programma implica il caso e la necessità, l’informazione implica il simbolo e l’improbabilità.
Una definizione ampliata di fotografia può quindi essere questa: la fotografia è un’immagine generata e distribuita automaticamente e necessariamente nel corso di un gioco basato sul caso da apparecchi programmati, un’immagine di uno stato di cose magico, e i cui simboli informano i destinatari, affinché assumano un comportamento improbabile.
Questa definizione suscita contraddizione, che è una delle molle della filosofia. Questa definizione è quindi un punto di partenza per una filosofia della fotografia.
La filosofia della fotografia deve rivelare che nell’ambito degli apparecchi automatici, programmati e programmabili non vi è posto per la libertà umana, per mostrare infine come sia comunque possibile aprire uno spazio alla libertà.
I fotografi compiono gesti che sono programmati dall’apparecchio fotografico, si interessano alle informazioni, creano cose prive di valore e pensano di agire liberamente in questo.
Ma c’è un’eccezione: i fotografi sperimentali. Quelli che sono coscienti del fatto che immagine, apparecchio, programma e informazione sono i problemi fondamentali con i quali confrontarsi. E si sforzano di produrre informazioni impreviste, di estrarre qualcosa dall’apparecchio e di mettere in immagine ciò che non figura nel suo programma. Anche se neppure loro sono coscienti del fatto che stanno cercando di fornire una risposta alla questione della libertà nel contesto generale degli apparecchi.
La filosofia della fotografia è quindi necessaria perché ha il compito di riflettere su questa possibilità della libertà.
Dati del libro
Titolo: Per una filosofia della fotografia
Autore: Vilém Flusser
Traduttore: Chantal Marazia
Tipo di copertina: flessibile
Numero di pagine: 117 pagine
Editore: Mondadori Bruno
Collana: Testi e pretesti
Data di pubblicazione: 1 gennaio 2006
Lingua: Italiano
ISBN-10: 8842499781
ISBN-13: 978-8842499787
Ascolta questo contenuto
Se preferisci ascoltare il riassunto del libro capitolo per capitolo invece di leggerlo, guarda questo video:

 Autore:
Autore: